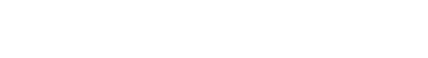Silvia Plath, una delle voci poetiche più straordinarie dell’America degli anni Cinquanta, nacque a Boston nel 1932 e mostrò fin da piccola una intensa propensione alla poesia e alla malinconia, accentuata dalla morte prematura del padre, stimato entomologo di origine tedesca, quando lei aveva 8 anni.
Nell’adolescenza e nella giovinezza la malinconia si trasformò in angoscia esistenziale ed esiziale, dal cui gorgo non uscirà mai.
E allora saranno ricoveri in manicomi in cui sperimentò anche la terribile esperienza dell’elettroshock.
La sua anima tormentata e la fragilità del suo equilibrio psicologico si riverberano nelle sue poesie e nel romanzo semi-autobiografico “La campana di vetro” scritto nel 1953 sulla spinta emotiva di una gravissima crisi depressiva.
I graffi dell’anima e l’instabilità psichica che l’attanagliavano non le impedirono però di laurearsi brillantemente e di diventare una delle esponenti più in vista della cosiddetta “poesia confessionale” americana.
Nel 1955 vince una borsa di studio per Cambridge dove conosce il Poeta Laureato Ted Hughes una delle menti poetiche più illuminanti di quegli anni, nonché uomo fascinoso e seducente come pochi.
Si amano furiosamente, accomunati da una passione rapinosa e rapace e dal comune “furor” poetico (anche se nella coppia è lui quello più potente e visionario).
Un’alchimia corroborante ed incendiaria, che però, nonostante la nascita di due figli, le regala sì momenti di gioia abbagliante ma non la rasserena. Affatto.
La scoperta della relazione di Ted con Assia Guttman, moglie del Poeta David Wevill, la fa precipitare nello sconforto più desolante.
La sua instabilità emotiva e psichica si accentua, si aggrava. “Parlo con Dio ma il cielo è vuoto”, scrive desolata e poi distrugge in un empito di gelosia l’unica, preziosa copia dei sonetti di Shakespeare su cui suo marito aveva annotato appunti di critica letteraria. Ne deriva una lite rabbiosa e l’inizio di una crisi irrecuperabile.
“V’è un muro bianco, obliquo al cielo, sopra il quale il cielo si ricrea infinito, verde, assolutamente intoccabile. Gli Angeli vi nuotano e le stelle, anche loro indifferenti. Sono il mio medium”.
Un grido lacerante, il suo. Un grido inascoltato.
E li raggiunse quegli Angeli, in una livida giornata invernale.
Il mattino dell’11 Febbraio 1963 nel suo appartamento londinese al numero 23 di Fitzroy Road, Silvia preparò pane, burro e marmellata e due tazze di latte e li appoggiò senza far rumore sul comodino della cameretta dove i suoi due bambini dormivano ancora.
Poi sigillò le finestre di casa con nastro isolante, la porta della cucina con asciugamani bagnati, e infine infilò la testa nel forno a gas. Aveva 31 anni.
Suo marito Ted distrusse l’ultimo volume del diario di sua moglie, quello in cui descriveva il periodo trascorso insieme.
Assia, l’amante del marito, colei che aveva innescato l’ultimo atto della sua convulsa e fragile esistenza si suiciderà qualche anno dopo insieme alla bambina che aveva avuto da Ted Hugues.
E a 46 anni anche Nicolas, il secondogenito di Ted e Silvia, porrà fine alla sua Vita, impiccandosi nella sua casa in Alaska, dove aveva scelto di vivere isolato dal mondo, solo, con i fantasmi della sua mente.
Sua madre in primis.